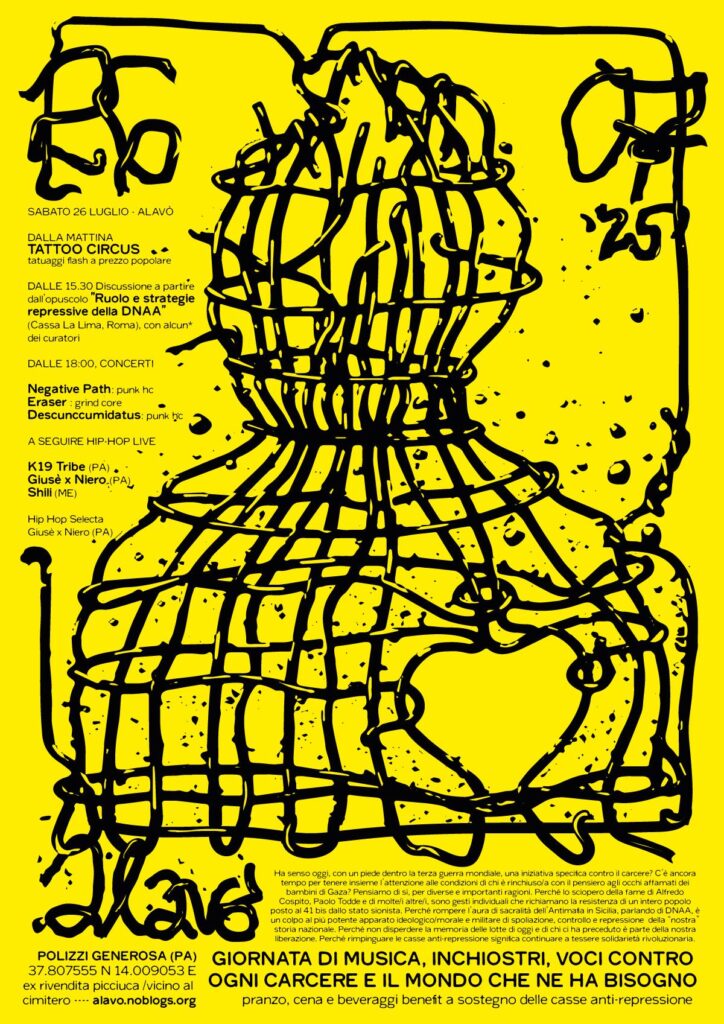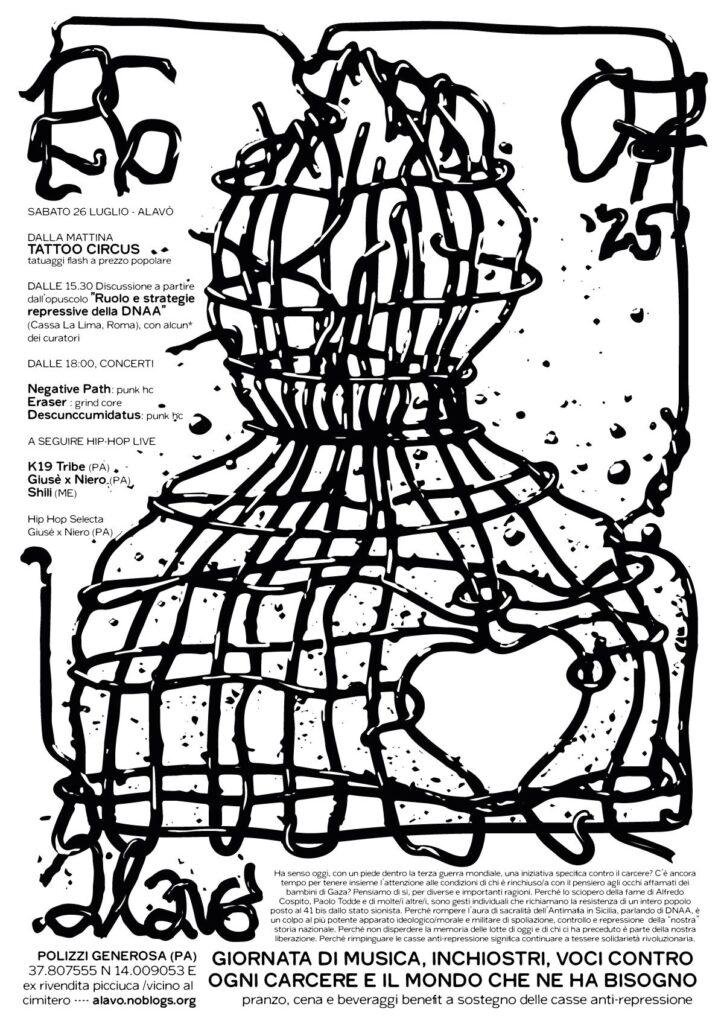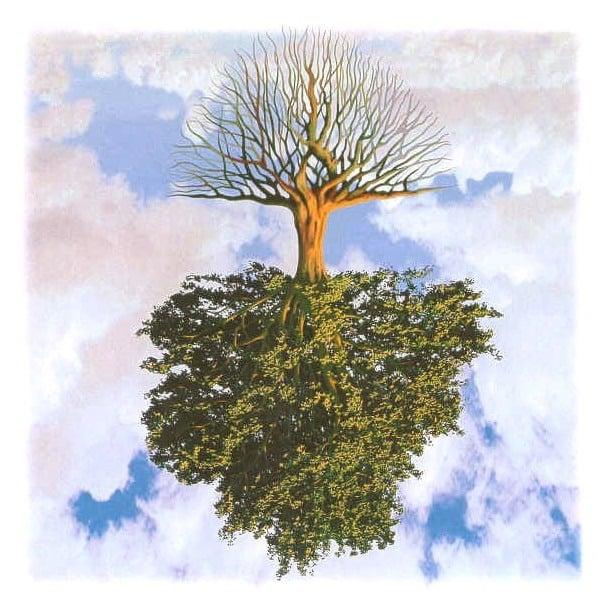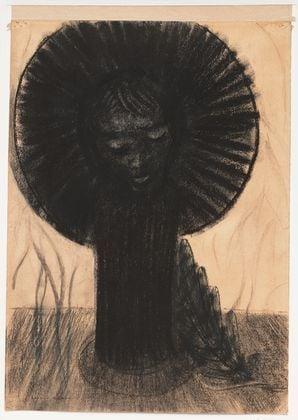
Riceviamo e pubblichiamo questo testo acuto e irriverente che viene dalla Francia, per il quale ringraziamo la compagna che lo ha tradotto, pensando a noi per la sua pubblicazione (per ragioni di cui diremo più avanti). Si tratta di un testo che ha diversi meriti. Il primo, quello di non cercare adepti: chi scrive parla per sè e, affidandosi alla penna come una lama per andare al cuore delle cose più che per fare ghirigori che piacciano a chiunque legga, scava uno spazio di indagine dove le questioni scottano e nessuno/a può scaldarsi nella sicurezza dei propri focolai teorici.
Il secondo merito è di attualizzare la memoria di un passato recente a rischio rimozione. Qui, infatti, si ripercorrono alcune vicende accadute nel biennio virulento del 20-22, su cui la scure della rimozione si accorda con gli interessi della repressione (e della depressione): l’ondata di sabotaggi che soprattutto in Francia, ma qualcosa avvenne anche in Italia, fece capitolare diversi ripetitori della telefonia mobile e di internet. Essendo questo blog nato in quegli anni, in supporto ad un omonimo giornale di contro-informazione che fu tra i pochi a dare notizia di queste azioni dirette, questa coincidenza ci fa contenti (siamo anime romantiche). Poi, c’è un punto di contatto, infatti nelle righe che seguono ci si addentra in temi su cui, chi anima questo luogo virtuale, ha scritto; se – si capirà senza fatica – le posizioni e i risultati sono molto diversi, ci sembra analogo l’ethos verso la vita/lotta in cui si mescolano esperienze dirette, passione rivoluzionaria, tensione individuale e storia/storie collettive. C’è, insomma, legna perché questo fuoco continui ad ardere.
* L’articolo è apparso in francese nel primo numero, di giugno 2024, della rivista La Houle. Per richiederne copie cartacee, si può scrivere all’indirizzo bouteillealamer@riseup.net
Note sulla traduzione
Nel tradurre bene un testo spesso non si valuta quanto lo spostamento spazio-temporale possa modificarne il significato, quindi vanno precisate alcune cose.
Questo testo è stato scritto in un contesto particolare : quello della Francia, dove nella scia delle ZAD il concetto di territorio era diventato centrale in gran parte dei movimenti autonomo, libertario e anarchico, e il “retour à la terre” un fenomeno generale, fino a rappresentare un fine in sé. Inoltre era il periodo post-confinamenti, nel quale, dopo aver sentito le cose più strane e contraddittorie venute dagli stessi movimenti, c’era bisogno di presentare il conto.
Ma questo testo non punta a rifiutare ogni riflessione e sperimentazione nell’ambito del territorio e della comunità, opponendovi la sola azione offensiva (pare che chi l’abbia scritto sia pure andato a vivere in campagna…). Intendeva per contro, in un certo contesto, sottolineare che se territorio e comunità servono quale sostituto mitico alle prospettive di lotta e non le appoggiano nei momenti giusti, cioè nei momenti in cui il reale può sorgere dietro al velo dell’irreale, allora sono anch’essi una truffa.
In Italia, il ritorno alla terra ha delle caratteristiche un po’ diverse, per la storia delle migrazioni interne, per il livello di repressione del movimento anarchico, e forse anche perché il modello della lotta territoriale non ho avuto lo stesso peso che in Francia. Ma spesso ritornano le medesime tematiche, e non a caso: esplorare le tensioni tra lotte, radicamento, ma anche spiritualità, è una dinamica già in corso in tanti contesti. Una dinamica spesso spinta da un’ideologia ecologista (molto più che marxista) che cerca di impiantarsi per legittimarsi.
In realtà, da anni la questione del radicamento ci sembra secondaria. Dai monti alle città, la questione sarebbe piuttosto: come rinforzare le offensive che, ben oltre la penisola, puntano la fabbrica dello sradicamento, guerra e tecno-scienza.
E se ci fosse bisogno di una certa irreperibilità? E di una capacità a non aspettare sempre la comunità?
La libertà non nasce da un solco
Risposta a Terre et liberté
Durante gli anni 2020-21, diverse centinaia di ripetitori sono stati sabotati in Europa. In precedenza la pratica esisteva già in maniera sporadica, associata ad una critica al ruolo della tecnologia dell’informazione nei dispositivi di potere. Da allora, si è diffusa e perdura.
Anche se qualche ministro sinistro, alto funzionario di polizia, o magnate della stampa hanno cercato di associarli a delle posizioni strambe, complottiste, antisemite e così via, questi atti sono ormai conosciuti da tutti. Resteranno un simbolo di resistenza durante i confinamenti, e più globalmente un simbolo di rifiuto del controllo tecnologico.
Ciononostante, una gran parte di coloro che esprimono pubblicamente delle critiche radicali è rimasta muta sul tema.
Senza dubbio ha giocato la paura di essere associati al complottismo. E anche la paura di essere associati tout court a questi atti. Ma quando si evita di compromettersi, quando si elude il presente, la radicalità arrugginisce e le critiche rammolliscono. Perché il pensiero si affina quando si scalda vicino all’azione, e si impantana quando se ne allontana. Ancora di più se gli avvenimenti stanno rimescolando le carte delle norme sociali, e la storia prende una svolta più buia. Per pensare liberamente bisogna esercitare la propria libertà. Ora, uno degli effetti del periodo covid è stato proprio il riposizionamento delle tensioni tra libertà, comunità e azione.
1. Terre et liberté
C’è un libro apparso alla fine del 2021 che ha ricevuto un certo successo: non è per la clamorosa novità del discorso, poiché Terre et liberté – questo il libro – non era ancora uscito che sotto molti aspetti era già un po’ sorpassato. Nel 2021 la solfa del ritorno alla terra, della Zad e del Chiapas non era né nuova né indispensabile. Né di scottante attualità.
Il successo del libro riguardo piuttosto il suo lato didattico, e la buona idea che ha avuto Aurélien Berlan – questo l’autore – di definire la libertà degli industrializzati come una volontà di délivrance1. Sì, per un industrializzato – sei tu sono io siamo noi – essere libero è essere liberato dalle fatiche, dalle pene, ma anche dalle malattie, o persino, a volte, dello sforzo di pensare – questo l’aggiungo io. Essere in grado di far fare il lavoro agli altri, altri resi invisibili (poiché ci sono degli schiavi dietro i vostri oggetti tecnologici, se osservate ve ne accorgete), questo sarebbe essere liberi. Almeno per i borghesi versione 3.0 e per coloro che vogliono assomigliare loro. Non dover più agire. Divenire addirittura incapaci di farlo. Per quella gente lì, in fondo, la libertà è non fare fatica, è la pigrizia.
Ma questo non vuol dire che invertendo l’equazione si possa proporre una definizione più pertinente. Orbene, ecco la proposta dell’autore di Terre et Liberté: la libertà, è provvedere ai propri bisogni attraverso una comunità legata alla terra.
Se volete farvene voi stessi un’idea, leggete il libro. Se vi sembra troppo faticoso (attenzione, è un tranello), potete dare una scorsa alla sua recensione esasperata nell’ultimo numero di Avis de Tempête di dicembre 20222, che, purtroppo, ha soffiato un po’ a lato della questione: scandalizzarsi del modo di vita dell’autore e della reputazione delle sue frequentazioni non costituisce una risposta al contenuto. Che l’autore sia un buon anarchico, un pessimo anarchico, o che non lo sia per nulla, in fondo ce ne freghiamo. E non sarà del resto la sua più grande colpa: il suo torto è di non aver saputo cogliere ciò che poteva essere oggi un’idea di libertà opposta a quella di délivrance. Forza, non ci resta che provare a attraversare il pantano.
Nonostante le sue qualità didattiche e le sue buone analisi, questo libro mi ha irritato, con la sua maniera di vedere tutto il bene nella comunità, e tutto il male nelle ipotesi che contemplano altri sentieri. E come amalgama grossolanamente individuo liberale e indipendenza d’azione! Senza l’approvazione della massa, nessuna legittimazione politica? Ogni azione dovrebbe quindi essere allineata ad un movimento? Eppure la realtà, antica o recente, racconta altre storie. Ma non è ancora questo l’essenziale: nel 2020-21, quando scrive il libro e un’ondata di sabotaggi antitecnologici attraversa l’Europa occidentale, durante la quale, bisogna pur ricordarlo, i movimenti come i Soulevement de la Terre hanno brillato per la loro assenza, l’autore non ha visto due cose. Una: non si è accorto che sono avvenute decine di azioni anti-tec, o si è semplicemente dimenticato di parlarne nel suo libro. Strana miopia politica. Due: non si è accorto che la nozione di libertà, dalla fine del ciclo delle Zad e la gestione tecno-medicale delle popolazioni post-covid, ebbene questa nozione di libertà si è ulteriormente spostata. Caramba…
2. Comunità contro libertà
Scrivere, come agire, è una questione di situazione. Se qualche anno fa potevamo ancora percepire delle prospettive comunitarie pertinenti, la pacificazione di Notre-Dame-de-Landes prima, poi l’accrescimento del controllo e dell’auto-controllo dal covid (dietro il pretesto di non contaminare la comunità), sono stati dei rivelatori. Hanno scisso queste due nozioni: libertà e comunità sono diventate estranee. Che sia un microcosmo alternativo o la società nel suo insieme, la comunità confinata e auto-controllata si è alienata la libertà. Per convincersi basta dare un’occhiata alle posizioni dei militanti virtuali come il blog Cabrioles, per l’ “#autodifesa sanitaria”, secondo il quale, poiché il virus attacca i più deboli, contraddire o levare le misure sanitarie post-covid rientrerebbe in una logica da privilegiati, irresponsabili, validisti, e eugenisti (eugenisti perché i malati sarebbero i sacrificati di una selezione del più forte). Tutto questo annuncerebbe un nuovo fascismo. Ma certo. Questi coraggiosi blogger e twittatori dell’estremo, riflesso caricaturale di posizioni tristemente diffuse, prolungano la logica dell’autorità tecno-medicale di Stato, la politica dell’obbligo vaccinale, di sperimentazione biomedicale, di controllo tecnologico. Ma poiché nella loro logica la vittima di un fenomeno ha per forza ragione, dato che è per forza legittimata a determinare come gli altri debbano vivere, arrivano a capovolgere la realtà: l’eugenetica non sarebbe più lo sviluppo di tecniche di manipolazione genetica, o la medicina di massa, ma il fatto di disobbedire all’ordine sanitario. L’individuo dovrebbe rispettare le regole per proteggere la comunità dal male, e la comunità dovrebbe sottomettersi al controllo, pena il generare delle ingiustizie. Ecco qui la posizione dominante dei radicali durante il covid. Tuttavia la posizione media è stata il dubbio, l’inazione e, in alcuni casi, il sostegno alla resistenza anti-tecnologica in corso. Anche se la stampa era riuscita a distillare la confusione sul senso delle pratiche di sabotaggio, nel 2020 apparvero dei testi chiari, come la lettera di Boris3, scritta in prigione nel giugno 2021, che avrebbero dovuto, a quel punto, illuminare gli analisti.
Sebbene Terre et Liberté costruisca una critica della società tecnologica per ridefinire la libertà, l’autore non trae da questi avvenimenti le conseguenze sulla nozione di comunità.
Dai ripetiamolo ancora una volta per coloro che strimpellano sui loro smartphone, li in fondo : la comunità, dopo questo episodio, si è inimicata la libertà. Non per sempre, ma quanto meno per un po’. Bene ma quindi, se non si trova nella comunità, cosa può voler dire la libertà, qui ed ora?
3. Da dove agiamo
Nelle parti del pianeta in cui il tecno-capitalismo è un intruso, in quegli anfratti del mondo dove il capitale e l’industria sono dei fenomeni che vengono da altrove, che tentano di invadere dei territori dove sopravvivono ancora altre culture, là, può essere, esiste ancora una forma di stato di libertà. Una libertà stabilita, continua, geograficamente situata e vissuta, in quanto basata su una comunità, un territorio, una cultura. E anche se non fosse totale, questa libertà sarebbe difendibile, di fronte agli attacchi venuti dall’esterno, come su una linea del fronte. Può essere. Ammettiamo, per puro esercizio mentale, che esista magari un tale stato di libertà, in cui uno possa nascere, vivere e morire, che si possa coltivare, e difendere. Dai, non mi va, ma faccio uno sforzo.
Al contrario, in seno al tecno-capitalismo, e a fortiori in Occidente, il potere è già qui. È diventato immanente, da decenni, secoli addirittura. In Europa, le ultime comunità economicamente autonome, contadine, relativamente indipendenti dall’economia di mercato, sono state disciolte dai massacri della prima grande guerra industriale e dalla modificazione dell’agricoltura che ne è seguita (meccanizzazione, pesticidi, produttivismo). Qui il potere è interno. E non è un’ipotesi. Qui ogni classe, ogni identità, ogni individuo e ogni comunità ricomposta sono ancora, a priori, dei ripetitori, degli hub del potere. Noi non ce l’abbiamo di fronte, noi ci troviamo in terreno nemico, dietro le sue linee. Qui, quindi, la libertà stabilità è necessariamente un’illusione di libertà. Nella realtà, se pensate di essere liberi, o siete dei buoni bio-cittadini potenti, dei borghesi 3.0, e quindi non avete sensi di colpa, poiché la società vi concede un margine di manovra più ampio, vi libera da tutto, generando così il vostro sentimento di libertà. Oppure siete un senza-potere, chiamato a produrre valore tramite il lavoro, la consumazione e la generazione di dati, e che altera la propria coscienza grazie a delle alternative di sintesi, o dei miti riscaldati.
Ma non siamo in Chiapas. Né in Kurdistan, né nella Spagna del ’36.
4. Rottura del tempo del potere
E a mio avviso la più grande lezione degli zapatisti, dei curdi e dei rivoluzionari spagnoli non era il legame tra la comunità e la libertà, ma il legame tra la preparazione e l’insurrezione. Al riguardo siamo molto d’accordo con Avis de Tempete, ed è il piccolo dettaglio della storia sul quale non insistono troppo i rivenditori d’immaginario comunitario, che sentiamo quotidianamente nei giri militanti: per dare vita a queste comunità in lotta ci sono volute delle armi, dei gruppi d’azione, delle reti clandestine, dei rifugi, dei falsari, dei rischi e del tempo, senza parlare dei condannati, delle donne violentate, e dei morti. La libertà non capita all’improvviso, o a forza di nominarla. Si fomenta, si allena, si cospira, e eventualmente si paga cara. Comunque sia, si esercita. La libertà, nel mondo tecno-capitalista, si può solamente praticare. È uno stato di eccezione, una sospensione del tempo del potere. Magari non sarà per sempre così, ma non sembra proprio che stia per cambiare. E se la guerra continua di stendere la sua presa sul mondo, questa situazione rischia addirittura di durare.
Quindi nei territori del potere non c’è libertà che come gesto di liberazione. Qui è l’atto, la temporalità dell’atto offensivo, che libera. Perché è una rottura del ritmo dominante, dell’ipocrisia, e anche una rottura materiale. Una rottura concreta delle infrastrutture del potere. Parziale, temporanea, sì, può essere, ma non immaginaria. Quel momento non è l’istante di godimento per la pietra lanciata, o il fuoco acceso: questa è la concezione patriarcale del gesto eroico. Questo tempo dell’azione offensiva comincia dalle complicità del progetto, è nei preparativi, nei rompicapo tattici e nelle preoccupazioni dell’attesa. È nei colpi di mano di un complice, negli sguardi che fanno affidamento, e nei combattimenti mentali contro la paura. Nelle mutazioni dei ruoli che possono avvenire nel processo. In tutti quei gesti in cui i nostri gruppi, a volte qualche paio d’occhi, si preparano e agiscono contro il potere, frantumiamo dei pezzi di questo mondo, allo stesso tempo in noi e fuori da noi.
Sebbene nasca nella pancia, questa libertà non è individuale, poiché non esisterebbe senza gli incontri magici, senza i complici sui quali appoggiare il proprio coraggio. Ma bisogna ben riconoscere che è limitata: questa libertà degli uni non fa quella degli altri. Palesemente, il fatto che io agisca non porta necessariamente gli altri a farlo. I bravi cittadini non si trasformano in complici come per magia, alla vista di un’antenna bruciata o durante un’interruzione dell’elettricità. Né gli alternativi, o gli anti-industriali del resto, il che è più difficile da ammettere.
5. Coniugare comunità e azione
Se sentite il bisogno di liberarvi in molti, cioè di agire in molti, allora perché fantasticare di una comunità del quotidiano, una quotidianità dell’autonomia in pieno giorno? A parte per colmare la solitudine, qui da noi è un miraggio: non siamo in Chiapas, dovete abituarvi. Bisogna ripeterlo: non siamo ai margini del tecno-mondo, ci siamo dentro in pieno! Noi siamo lui e lui è noi. Qui, l’autonomia e la libertà che si toccano, che si confondono, che hanno senso, stanno nell’autonomia d’azione. È agire con senso e precisione, magari con una strategia, ma senza attendere che tutto il mondo lo faccia, senza attendere che la comunità convalidi. È la libertà nella notte, nella nebbia degli altri.
Ma c’è ancora di peggio: nel nostro mondo, per il momento, una comunità di vita quotidiana e una comunità d’azione possono difficilmente sovrapporsi, coesistere apertamente, poiché presterebbero il fianco ad una repressione feroce. La comunità di giorno è identificabile, localizzabile, e dipendente dalle sue infrastrutture materiali. La comunità di notte dev’essere invisibile, anonima e mobile. La prima sarà tentata di tradire la seconda per sopravvivere, e alla fine saranno spazzate via entrambe. Qui non abbiamo né popolo, né cultura, né antenati da difendere. Nessuna terra santa, nessun isola di Tortuga. La comunità nella libertà, per il momento, è trovare delle persone di fiducia, e con esse il cammino dell’azione. Oppure possiamo continuare a sedarsi con Damasio e Pignocchi4 e Netflix, e illuderci che questo mondo cambierà perché ne immaginiamo un altro. In ogni caso non funziona molto per il momento, sarà perchè non immaginiamo abbastanza intensamente. Questi spacciatori di miti, questi venditori di ecologia di sintesi, o di ribellioni asetticizzate, stanno alla rivolta come il porno sta al piacere: vengono a riempire i vuoti di questo mondo, e poi fabbricano dei mondi vuoti.
Eppure ci sarebbero dei modi di coniugare delle forme di comunità alla libertà dell’agire. Ma questo implicherebbe lo sviluppo di una cultura della resistenza, secondo una formula un poco alla moda. Il coltivare una ganga fluida, opaca e porosa intorno alle cellule offensive. I maoisti dicevano una volta che i rivoluzionari dovevano stare in mezzo al popolo come i pesci nell’acqua? La nostra etica anarchica non ammette una tale boria. E poi il popolo, oggi, è un miraggio: più ci si avvicina, più si allontana. Ma delle comunità potrebbero scegliere di essere per i gruppi d’azione ciò che le foreste sono per le bestie feroci. Certo, nella realtà, quanti sono oggi quei comunardi, quei ritornati-alla-terra, che propongono di aprire le loro porte, le loro dispense, i loro portafogli, o – peggio – le loro agende, a una complicità che potrebbe pure rivelarsi estremamente fertile? Quante sono queste comunità dove si fa esistere una cultura della sicurezza, o dove si valorizza allo stesso modo l’analisi critica e radicale e la cultura del radicchio, e del cavolo? Poca cosa. Perché una tale cultura della resistenza si sviluppi, bisognerebbe per prima cosa prestare un po’ meno l’orecchio agli immaginari in kit, che autogiustificano la comunità nel suo sviluppo materiale e spirituale, e un po’ più agli atti concreti che però, però, sono la parte palpabile, la punta dell’iceberg, la piccola incarnazione nella nostra realtà, di questo grande sogno che noi abbiamo probabilmente, e nonostante tutto, in comune: vedere questo mondo indebolirsi, oscurarsi, e vederne altri che emergono.
Se questo mondo ci lasciasse la scelta se vivere liberi o meno, sarebbe semplice: ci sarebbero due umanità, a sinistra quelli che vogliono la libertà, a destra gli altri, ciascun per sé. Ma non è così. Se ci battiamo contro questo mondo, è proprio perché non lascia la scelta a nessuno. A questo punto, l’alternativa non è una prospettiva. E di fatto le comunità agricole non sono autonome, non possono esserlo all’interno del tecno-capitalismo. Non è nemmeno colpa loro: sono delle piante sradicate, irrigate e connesse ai flussi del grande meccanismo, come tutti. La libertà superficiale che vi gustiamo può talvolta essere un conforto, ma è pur sempre un’illusione di autonomia. Anche a me piacerebbe alzarmi al mattino, macinare a mano il mio caffè (del Chiapas) nella cucina collettiva, poi innaffiare il mio orto, prima di andare a distruggere la fabbrica di armi della città vicina, e tornare mano nella mano a farsi una tisana. Ma non è reale, questo, e non durerebbe cinque minuti. Ci battiamo contro questo mondo con quel che abbiamo, un piede dentro, un altro che cerca un oltre, e la testa incasinata a forza di arrancare tra due realtà.
6. Natura e libertà
Nella tensione che anima l’eco-anarchismo da più di una generazione, tra ecologia sociale e ecologia profonda, un’altra alleanza si oppone simmetricamente alla coppia libertà/comunità: quella della “natura come il binomio inseparabile della libertà5”. È un’altra variante di una concezione della libertà istituita. Il legame tra la natura e la libertà può essere inteso in due modi: la libertà si troverebbe in delle zone rifugio, negli altrove del regime tecno-capitalista, dove la natura si dispiega ancora, dove permette dei rapporti agli altri e a sé differenti. Però, secondo me, non ci sono più degli altrove, oppure sono molto angusti. Non c’è una foresta in Europa che non sia sfruttata, ripiantata, metodicamente cacciata.
Oppure la libertà si troverebbe in un dopo la caduta del regime tecno-capitalista, dove la natura rinascerebbe.
Sì, la natura concepita come la nostra grande casa e non come stock di materia sfruttabile, offrirebbe molte possibilità, se non fosse occupata quasi totalmente dal tecno-mondo. E sì, ci si trova meno costretti che nelle città e villaggi pieni di umani. Ma se trovo molte cose nella proliferazione degli esseri viventi e inerti, non ci trovo le basi di un’etica che possa fondare la nostra idea di libertà.
Salvo, può essere, che ogni esistenza sia limitata in sé ma si prolunghi attraverso gli altri, e che il gioco della libertà sia di fare con questi limiti?
* * *
C’è del vero in ciò che enuncia Terre et Liberté. Certo che l’autonomia, assumere le conseguenze a monte e a valle dei nostri stili di vita, in osmosi con il nostro ambiente, sarebbe una bella idea di libertà. In un mondo in cui fosse possibile. Salvo che non è la questione che si pone a noi oggi. Per il momento la libertà si esercita, o meno, ma non si istituisce.
E anche se tutto questo diventasse nuovamente possibile, allora la libertà dovrebbe essere persino più di questo. Non è forse anche in questo vecchio sogno di vivere tutti senza il giogo e senza le ingiustizie, e il sogno più recente di vivere senza la presenza permanente di un’ostilità macchinica intorno a noi? E senza la presenza della comunità suprema, lo Stato. E senza questa voce, diffusa dal potere, che sussurra dentro ognuno e ognuna di noi: “tu non sei niente”.
Ps: Tutte le critiche fatte in questo testo, anche quelle un po’ veementi, sono sempre fatte con amore. Salvo per Cabriole, non scherziamo. Né per Damasio, ci sono dei limiti. Né per P… bhe, abbiamo la lista, in caso di reclami.
1Il termine usato in francese è “délivrance”, il cui significato abituale è vicino a “liberazione”, ma che ha anche il senso della seconda parte del parto in cui viene espulsa la placenta, “secondamento”. L’autore di Terre et liberté lo usa per sottolineare quanto la libertà dei moderni sia un affrancarsi, un essere sollevato dal peso delle cariche materiali della propria vita. NdT.
2Bollettino anarchico per la guerra sociale : https://avisdetempetes.noblogs.org/post/2022/12/15/avis-de-tempetes-59-60
3Intitolato “Perché ho bruciato le due antenne del Mont Poupet”, quel testo rivendicativo scritto in giugno è stato publicato in vari siti.
4Autori francesi di fantascienza e di fumetti che ricevono un certo successo in ambito alternativo.
5En temps d’écocide, rivista Takakia#1, 2024